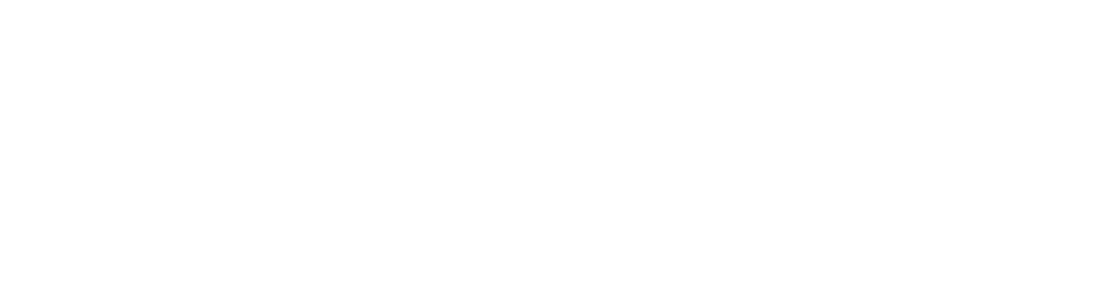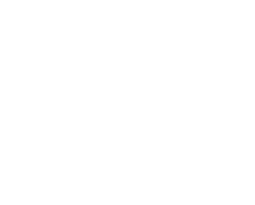MATERNITÀ E IDENTITÀ
Come evolve l’identità di una donna nelle diverse fasi della maternità?
Il bambino e il suo concepimento si formano prima nella testa e poi nel corpo della donna, e cosí come per concepire bisogna essere in due, le emozioni che attraversano la donna nelle diverse fasi della gravidanza e poi della maternità, nel corso degli anni, risuonano di tanti aspetti che coinvolgono la coppia genitoriale, cosí come degli influssi che il sociale necessariamente gioca sul modo in cui le donne percepiscono il loro essere madri.
La cultura di appartenenza determina fortemente il concetto di intendere la maternità alle diverse latitudini e nelle diverse religioni. Nella società occidentale i rapidi cambiamenti che si sono verificati negli ultimi cento anni hanno reso l’idea di diventare madre non più come un obiettivo scontato in assenza del quale sentirsi inabili e mancanti nei confronti della comunità, piuttosto come un sogno da nutrire e mantenere vivo negli anni della formazione e della crescita professionale, tra il desiderio di un figlio e il timore delle rinunce che una scelta responsabile sempre comporta.
Difficile parlare quindi di una identità che si evolve in maniera univoca nelle donne rispetto alle differenti fasi della maternità, ma forse può aiutarci immaginare la donna come la stratificazione e il risultato di un processo multiforme di trasformazioni in atto nel corso del suo sviluppo di persona, da bambina ad adulta, che risentono di variabili che attingono alla propria esperienza con la propria madre, all’esempio ricevuto in famiglia rispetto al ruolo della donna nell’accudimento dei figli, alle relazioni significative delle quali ha fatto esperienza e che si costituiscono come gruppi interni che regolano il suo sentire e il suo agire.
Quali risorse emotive, quali fragilità, vede emergere più spesso nelle madri che segue?
Le donne portano sempre il tema dei figli quando si prendono cura dei loro pensieri e delle loro emozioni attraverso una psicoterapia. Emerge di frequente la difficoltà che incontrano tra il porsi come contenimento dei figli anche attraverso il valore dato a regole condivise e rispettate, la funzione di accudimento e protezione tipica della funzione materna e la necessità di favorire l’autonomia di individuo del proprio figlio.
Sono sempre le madri che accompagnano in terapia un figlio che sta incontrando delle difficoltà ad affrontare la vita. Se si riesce ad utilizzare questo aggancio per una riflessione che coinvolge non solo il ragazzo, ma anche i genitori e la famiglia nel quale è inserito, allora una maggiore consapevolezza delle dinamiche in atto in seno al gruppo famigliare consente a tutti di stare meglio.
Quanto conta il confronto e la condivisione tra donne in un percorso così ricco?
Le cose importanti si fanno insieme agli altri. Partendo da questo presupposto, possiamo pensare che avere la fortuna di poter condividere gioie, dubbi e preoccupazioni con altre madri costituisca comunque una risorsa e fornisca la possibilità di non rimanere isolate, di guardare ad altri punti di vista favorendo la consapevolezza e la riflessione su temi rispetto ai quali, a volte, il confronto con il partner non riesce a svilupparsi senza tensioni, o di guardare ad aspetti riguardo lo sviluppo dei nostri giovani che in alcuni casi sembrano non essere “visti” in seno alla famiglia.
Quali modelli positivi possiamo coltivare oggi per accompagnare la maternità in modo più completo e rispettoso?
Non mi piace parlare di modelli, perché credo colpevolizzi la donna rispetto ai suoi limiti e alla responsabilità di accompagnare il proprio figlio in un percorso di evoluzione. La madre perfetta non esiste e, come riportano le donne, non esiste il manuale di istruzioni.
Mi vengono alla mente due concetti sviluppati da psicoanalisti che hanno dato un contributo enorme alla comprensione delle dinamiche tra mandre e bambino: Melanie Klein parlava dell’importanza di una fase fusionale tra madre e neonato, presupposto indispensabile per costruire quel senso di appartenenza e contenimento necessario allo sviluppo della mente del bambino, ma insieme di quanto fosse necessario gradualmente accompagnare il bambino nel processo di individuazione da lei verso lo sviluppo della sua autonomia; Donald Winnicott ha elaborato il concetto di “madre sufficientemente buona”, colei cioè che intercetta i bisogni del bambino e ne favorisce la soddisfazione ma senza anticiparli e risolverli, impedendo cioè che egli possa percepirli, iriconoscerli, mparare a stare nella frustrazione di non poterli soddisfare immediatamente e possa attivare autonomamente le proprie risorse. È la madre che insegna al figlio l’affettività e a riconoscere ed esprimere le emozioni e i propri sentimenti. Una madre che gli restituisce costantemente la dimensione del suo valore e gli consente di sviluppare la propria personalità provando amore per se stesso e per gli altri.
Confrontarsi in gruppi di sostegno alla genitorialità aiuta a condividere pensieri, e pensare insieme è sempre un processo generativo di idee creative.
Intervista realizzata dalla giornalista D.ssa Palma Grano per Cooperazione dell’8 maggio 2025